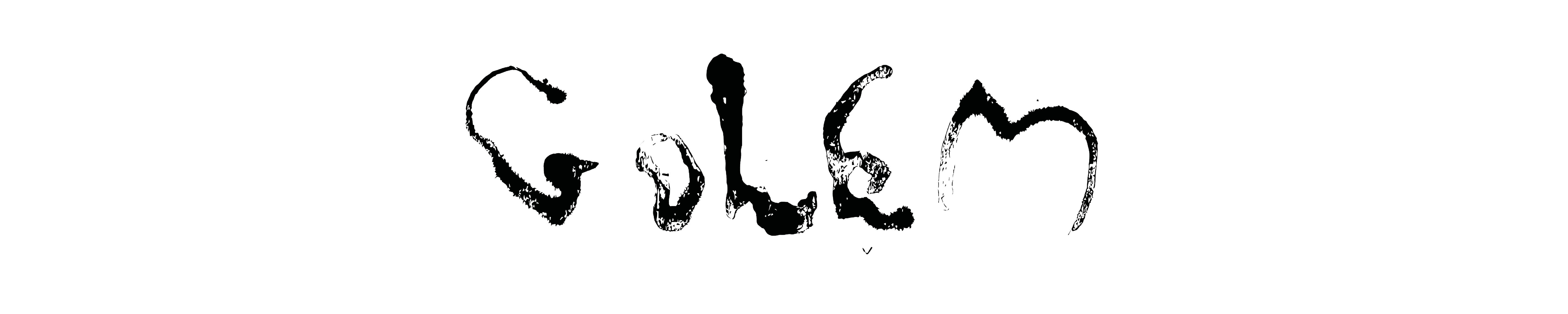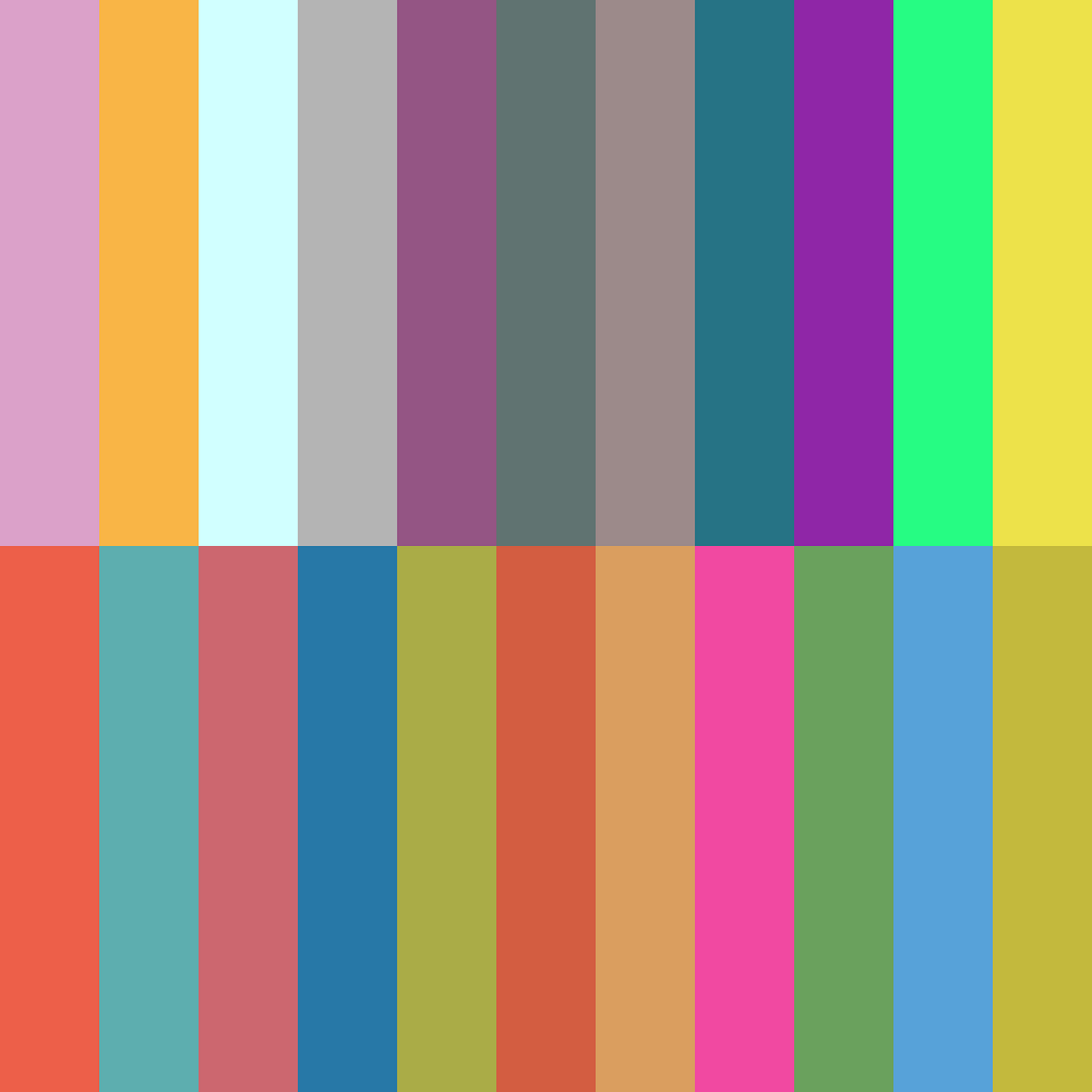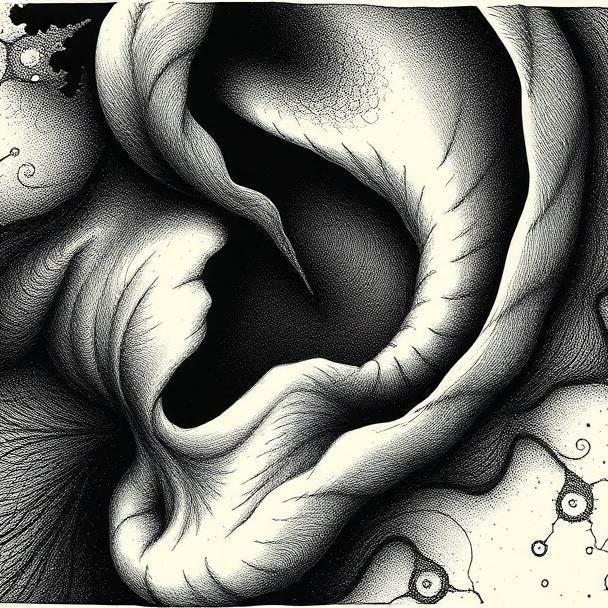Newsletter#022
Pratiche sonore, ascolto situato e spazio pubblico.
Una conversazione con Elena Biserna, Nicola Di Croce e Leandro Pisano
Il 17 giugno 2023, a Palazzo Fabroni (Museo del Novecento e del Contemporaneo di Pistoia), si è tenuto un incontro pubblico moderato da Carola Haupt (Radio Papesse) con Elena Biserna, Nicola Di Croce e Leandro Pisano. L’incontro si inseriva nel public program della mostra Mezz’aria, curata da Nub e Gabriele Tosi, che ha proposto una serie di pratiche e riflessioni intorno al suono, allo spazio e alla relazione tra arte e ascolto. La conversazione ha toccato diversi aspetti legati all’ascolto come pratica critica, situata e relazionale. Si è discusso del modo in cui l’ascolto contribuisce a definire lo spazio pubblico, della dimensione politica e percettiva della presenza sonora, e delle sue implicazioni sociali e culturali. Elena Biserna è storica dell'arte e curatrice indipendente. Scrive, insegna, facilita workshop o progetti collettivi, cura iniziative e occasionalmente performa. La sua ricerca si concentra sull’ascolto e sulle pratiche artistiche contestuali e “situate” nelle loro relazioni con le dinamiche urbane, i processi socioculturali e la sfera pubblica e politica. Ha curato i volumi Walking from Scores (Les Presses du réel, 2022) e Going Out. Walking, Listening, Soundmaking (Umland, 2022). Nicola Di Croce è architetto, musicista, sound artist e ricercatore. È Marie Sklodowska-Curie Fellow presso l’Università Iuav di Venezia e la McGill University di Montréal. La sua ricerca si concentra sul rapporto tra urban studies e sound studies, con particolare attenzione agli approcci sonori, qualitativi, partecipativi e creativi all’analisi e alla progettazione delle politiche urbane. Leandro Pisano è curatore, scrittore e ricercatore indipendente. Si occupa delle intersezioni tra arte, suono e tecnocultura, con un focus sull’ecologia politica dei territori rurali, marginali e remoti. È autore del libro Nuove geografie del suono. Spazi e territori nell’epoca postdigitale (Meltemi, 2017).
La trascrizione che segue restituisce la conversazione nella sua interezza, con minimi interventi redazionali volti esclusivamente a facilitarne la lettura in forma scritta.
CAROLA HAUPT Vorrei iniziare da una frase tratta dal testo introduttivo della mostra, che mi sembra un buon punto da cui partire. A un certo punto si legge:
“L’essere narrante è colui che attraversa il mondo della mostra; è il visitatore, a cui la mostra si offre con massima accoglienza, modulando l’invasività dei fenomeni e collocando l’interazione di universi ludici e approcci umanizzati, lasciando spazio al piacere personale in forme leggere di disorientamento e unità collettiva.”
Perché voglio partire da qui?
Perché l’idea del narratore, e di come si possano costruire narrazioni sonore, è un tema che per me — e per noi di Radio Papesse — è particolarmente importante. È quello che cerchiamo di fare nel nostro lavoro: raccontare, ascoltare, collaborare con artisti, creare occasioni per riflettere sulle narrazioni sonore al di fuori degli schemi tradizionali. E credo che questo accada anche in un contesto come quello che ci ha riuniti oggi: si costruiscono mondi, si generano narrazioni.
C’è qualcosa che mi piace spesso ricordare, soprattutto quando mi chiedono cosa facciamo. Di solito rispondo che ci occupiamo di storie e di suono.
Attraverso le storie costruiamo la nostra percezione del mondo, il nostro stare al mondo. E raccontare o farsi raccontare storie è un atto che passa dal suono. È attraverso il suono che troviamo strumenti per orientarci, per costruire significati, per dare senso al mondo, o almeno al contesto in cui siamo immersi.
Vorrei iniziare condividendo anche un secondo spunto di riflessione tratto da un testo scritto da Leandro Pisano ormai diversi anni fa: Traslazioni sonore. Muoversi negli spazi acustici della contemporaneità post-digitale1.
È un testo complesso, ma ancora estremamente attuale, che offre numerosi spunti di riflessione. Molti dei temi che affronta — in forme diverse — si ritrovano in molte delle pratiche sonore contemporanee. Uno dei concetti affrontati in quel testo è il sonic nomadism, un termine ripreso da Budhaditya Chattopadhyay2.
Leandro, potresti raccontarci cosa intendi con questa espressione, e perché ritieni sia utile per pensare le pratiche sonore e le modalità con cui queste contribuiscono alla costruzione di senso?
LEANDRO PISANO La domanda apre uno scenario teorico piuttosto ampio, ma cercherò di essere il più chiaro possibile. Il concetto di sonic nomadism è piuttosto complesso. Nel mio lavoro lo ho elaborato soprattutto in relazione all’idea di post-digitale. Con questo termine non intendo un superamento del digitale in senso temporale o tecnologico — anche perché siamo ancora immersi in una fase di piena pervasività del digitale — ma piuttosto un atteggiamento critico nei confronti delle sue narrazioni dominanti. Mi riferisco, in particolare, a quelle pratiche artistiche che assumono una posizione di distanza — a volte anche antagonista — verso le retoriche entusiastiche e messianiche legate all’innovazione tecnologica.In questo contesto, ho fatto riferimento al concetto di sonic nomadism proposto da Budhaditya Chattopadhyay, che si inserisce in un ambiente in cui nuovi e vecchi media si ibridano, e in cui le tecnologie dell’informazione non sono più viste solo come strumenti di progresso, ma anche come dispositivi critici. Il sonic nomadism, da questa prospettiva, diventa allora un modo per mettere in discussione i discorsi egemonici sull’innovazione, per attraversare i territori, leggere le tensioni, interrogare lo spazio attraverso il suono e le pratiche artistiche.
CAROLA HAUPT Leandro, ti seguo, ma vorrei rilanciare una sintesi per rendere più chiaro il passaggio. Quello che mi pare tu stia dicendo è che esiste la possibilità di usare le pratiche sonore come dispositivi critici per interrogare le modalità di ascolto e il modo in cui ci muoviamo nello spazio acustico. È così?
LEANDRO PISANO Esattamente. È proprio da questa postura critica — e, in certi casi, antagonista — nei confronti delle narrazioni dominanti sul digitale che nasce l’interesse per ciò che definiamo post-digitale. Questa prospettiva porta alla luce una serie di trasformazioni profonde, che investono diversi livelli: politico, estetico, geografico, percettivo. L’aspetto interessante è che queste trasformazioni possono essere intercettate e attraversate attraverso i processi dell’ascolto. L’ascolto diventa una condizione che si definisce in relazione a questo scenario in trasformazione: uno scenario in cui si sovrappongono continuamente luoghi fisici e spazi dell’immaginazione, movimenti, corpi, flussi. È attraverso l’ascolto che costruiamo il nostro modo di abitare questi spazi, di attraversare i paesaggi, di relazionarci a ciò che li compone.
CAROLA HAUPT Vorrei allora passare la parola a Elena, riprendendo quello che hai detto anche tu, Leandro. In particolare, mi interessa capire come l’ascolto possa contribuire alla costruzione dello spazio, tenendo conto del fatto che è sempre un gesto sociale e politico. Come entra, secondo te, la dimensione collettiva e relazionale in un’esperienza di ascolto? E in che modo questa può trasformare lo spazio?
ELENA BISERNA Una cosa che ho apprezzato molto nel modo in cui è stata costruita Mezz’aria — e in particolare nella cura con cui si è lavorato all’allestimento e alla relazione tra i lavori — è il tipo di tessitura che si è creata tra le presenze degli artisti. Non si tratta di una semplice giustapposizione di opere o interventi, ma di un lavoro curatoriale attento, che ha messo in relazione pratiche diverse e ne ha valorizzato le risonanze reciproche. C’è un ascolto tra le opere, tra i gesti, tra le persone. E questo non è affatto scontato .Spesso, quando si affronta il suono in un contesto espositivo, ogni artista è collocato in uno spazio separato, con l’idea di creare condizioni di ascolto “puro”. Qui, invece, c’è stata un’attenzione a come le diverse presenze possano convivere, risuonare tra loro, creare echi inaspettati ma significativi. È una compresenza pensata, che valorizza ogni voce senza isolarla. E questo ci riporta a una domanda che mi accompagna da tempo: che cosa succede quando diverse voci si incontrano in uno spazio d’ascolto? Possono coesistere? Possono entrare in relazione senza cancellarsi a vicenda? Per molti anni ho pensato all’ascolto come una pratica capace di mettere in crisi alcune dicotomie radicate nella cultura occidentale — in particolare quella tra soggetto e oggetto, che caratterizza la visione prospettica. L’ascolto, rispetto alla vista, non si fonda sulla distanza o sull’oggettività, ma sull’attraversamento, sull’apertura, sull’intimità. Oggi però sento il bisogno di rimettere in discussione anche questo. Perché anche l’ascolto può riprodurre gerarchie, può escludere. Anche l’ascolto ha una posizione, non è mai neutro. E allora la domanda diventa: da dove ascoltiamo? Non solo in senso geografico, ma anche simbolico e politico: da quale condizione sociale, da quale privilegio, da quale storia?Questa domanda — da dove ascoltiamo? — è qualcosa che sto condividendo anche con altre persone, in percorsi collettivi di ricerca e riflessione. Tra queste, voglio ricordare Anna Raimondo3, con cui ho cominciato a interrogarmi proprio su questa prospettiva: da dove ascolto?. E quando diciamo “dove”, non parliamo solo di una collocazione geografica, ma di un posizionamento simbolico, politico, culturale. Qui faccio riferimento anche alla nozione di “saperi situati” elaborata da Donna Haraway 4, secondo cui ogni forma di conoscenza — e dunque anche di ascolto — è inscritta in una posizione, in un punto di vista parziale ma non arbitrario.
È un modo per parlare di ascolti situati, per interrogare da quale posizione ascoltiamo e come le voci sono distribuite nello spazio acustico. C’è un elemento molto concreto che mi aiuta spesso a pensare a tutto questo: il microfono. Il microfono è un dispositivo che permette l’accesso alla parola, ed è distribuito in modo diseguale. In questo momento, ad esempio, sono io a parlare e a tenere il microfono in mano. E per convenzioni sociali voi state ad ascoltarmi. Questa è una forma di potere. Una relazione regolata, che si ripete ogni volta che qualcuno prende la parola in pubblico. E questa possibilità — quella di parlare, di essere ascoltati — non è distribuita in modo equo nella società. Ci sono corpi che sono più udibili di altri. Corpi che sono sistematicamente esclusi dallo spazio della parola, o che devono continuamente negoziare la loro presenza sonora. Alcuni corpi cercano di rimanere sotto soglia, di non essere visti né ascoltati; altri monopolizzano lo spazio dell’udibilità, impedendo ad altri di esistere acusticamente. Mi interessa molto riflettere su queste dinamiche, e su come possiamo scardinarle, anche attraverso piccole pratiche di ascolto — attraverso il modo in cui ci posizioniamo, attraverso posture di ascolto e di presa di parola che si esprimono attraverso dispositivi, gesti, azioni.
CAROLA HAUPT Vorrei passare ora la parola a Nicola, perché molte delle questioni che Elena ha sollevato — il posizionamento, la responsabilità dell’ascolto, la costruzione di relazioni attraverso il suono — si ritrovano anche nel suo lavoro, in modo molto preciso.
In particolare, penso a una frase che hai usato per descrivere la tua pratica: “mi sono messo nella posizione di voler quasi scomparire nella superficie sonora”.
Vorrei chiederti: in che modo questa idea di posizionamento entra nel tuo lavoro, sia come artista che come ricercatore? E quali strumenti metti in atto per esplorare questa relazione tra ascolto e spazio?
NICOLA DI CROCE In realtà, tutto quello che è stato detto finora si lega anche al mio lavoro. A partire da ciò che dice Chattopadhyay sul nomadismo sonoro, fino alle riflessioni di Elena sull’ascolto situato. Forse si potrebbe partire da una difficoltà: capire fino a che punto il nostro ascolto è davvero situato. Tendenzialmente, diamo per scontato che la nostra presenza sia neutra. Che, quando ascoltiamo — o registriamo — stiamo semplicemente “catturando” qualcosa che è già lì, come un dato oggettivo. Ma in realtà non è così. Anche solo il fatto di essere presenti, con il nostro corpo, cambia inevitabilmente quello spazio, quella situazione. Questo è qualcosa che emerge chiaramente nella pratica della field recording. Quando mi trovo a registrare, mi chiedo: cosa sto registrando? perché lo sto facendo? E soprattutto: in che modo mi sto relazionando a quello spazio?
Il desiderio di “scomparire”, che prima è stato evocato, mi ha sempre colpito. È una sorta di paradosso. Non si può scomparire. Anche quando ci si sposta fisicamente, anche quando si usa un microfono lontano, si lascia comunque un’impronta.E questa pretesa — l’idea di potersi rendere invisibili — rischia di rivelare delle dinamiche problematiche. A volte anche coloniali, che è importante riconoscere e rimettere in discussione. Per questo credo sia fondamentale riconoscere la propria soggettività. Se sono lì, in uno spazio, ad ascoltare, non posso fingere di non esserci.E questo non per mettere al centro me stesso, ma perché quella presenza, quel punto di vista, è già in gioco. In un certo senso, è come fare una forma di auto-etnografia: la mia presenza modifica ciò che accade, anche se minimamente.E allora vale la pena chiedersi: che ruolo ha quella presenza? Come si intreccia con le altre? In molti dei progetti che seguo, l’ascolto diventa anche uno strumento per costruire consapevolezza collettiva. Per me è importante pensare l’ascolto non solo come esperienza individuale, ma come qualcosa che si mette in relazione. Una pluralità di ascolti, che si confrontano, si intrecciano, magari anche si scontrano. E credo che sia lì, in quella frizione, che si generi conoscenza. Non nella conferma, ma nella relazione tra differenze. L’ascolto è una pratica che ci attraversa, che ci posiziona.E forse, proprio per questo, può aiutarci anche a riconoscere le micro-prevaricazioni sonore che attraversano i nostri contesti quotidiani — e che spesso diamo per scontate.
CAROLA HAUPT E legato a tutto questo c’è anche il tema della condivisione. Anche quello che diceva Elena prima, sulla permeabilità: cioè costruire relazioni, costruire interpretazioni, costruire possibili interpretazioni di senso attraverso l’elemento permeabile del suono. Ora, non voglio entrare in tutte le teorie — che sono tantissime, e c’è chi ne sa molto più di me — però… Una delle caratteristiche fondamentali del suono è proprio questa: la capacità di attraversare, di modificarsi, di permeare gli spazi. La sua porosità, la sua capacità di occupare anche spazi liminali. E qui mi ricollego anche a quello che diceva Leandro: il suono ha questa capacità di entrare in spazi che altrimenti non potrebbero essere occupati. Nel caso della mostra, ad esempio, tutti i vari elementi, tutte le suggestioni, sono suggestioni che si intrecciano, si condizionano, si modificano l’una con l’altra. Invitano il visitatore a costruire un proprio percorso — proprio come quando si cammina dentro uno spazio urbano. E voi due — che vi occupate di suono e della costruzione politica e sociale dello spazio urbano — lo sapete: il nostro ascolto e la nostra presenza non sono mai neutri. Non sono mai separati da ciò che accade intorno.
ELENA BISERNA Questo elemento della porosità, e la possibilità di costruire soggettività collettive o plurali, si lega per me a un tema che mi sta molto a cuore: la materialità del suono.
Il suono è una vibrazione. È qualcosa che nasce sempre da un contatto: tra corpi, tra soggetti, oggetti e ambienti.
C’è quindi una dimensione molto fisica, molto concreta, che riguarda il modo in cui il suono attraversa i corpi, attraversa gli spazi, e rende spesso confusi i confini tra dentro e fuori, tra pubblico e privato. In un certo senso, li perturba un po’.
CAROLA HAUPT C’è una definizione che cito spesso, data da Brandon LaBelle, che trovo molto efficace: “il suono è relazionale per sua stessa natura.” 5
È anche uno dei principi alla base delle Transmission Arts6, dove si parte dall’idea che il suono sia sempre inscritto in una relazione: c’è un elemento che viene trasmesso, e uno che lo riceve. Il senso del suono si costruisce proprio in quella relazione, tra chi emette e chi ascolta.
ELENA BISERNA Forse posso partire da quello che faccio nel mio lavoro. Cerco di creare situazioni collettive di ascolto e di risonanza nello spazio urbano, a partire da una pratica di ascolto molto situata, da una modalità, da una posizionalità — che, nel mio caso, è legata anche al genere.
Le due partiture che ho scritto e che sono anche presenti in mostra nascono come attivazioni individuali: l’idea è che possano essere raccolte, lette, interpretate e performate da chi le incontra. Derivano da un progetto che ho iniziato nel 2014: una collezione7 di partiture verbali e grafiche dedicate al camminare, scritte da più di sessantacinque artistə — dagli anni Sessanta a oggi — provenienti da ambiti diversi: letteratura, musica, arti visive, architettura, attivismo politico. È un progetto che ho attivato in molte città. L’intento non era quello di esporre le partiture come oggetti statici, ma di organizzare gruppi di persone che potessero attivarle collettivamente, camminando insieme nello spazio pubblico. Dopo diversi anni, mi sono resa conto che nessuna delle partiture presenti nella collezione metteva esplicitamente in gioco la questione della posizionalità, in particolare rispetto al genere — ma anche rispetto ad altri fattori che condizionano concretamente il modo in cui si cammina nello spazio pubblico: l’età, il corpo, il possesso o meno di documenti, l’essere razzializzati o no, il genere, l’orientamento sessuale…Tutte queste dimensioni influenzano se, quando, dove e come possiamo camminare, e in quali spazi i nostri corpi possono effettivamente accedere. Così, nel 2018, in risposta a un invito specifico, ho scritto una prima partitura partendo dalla mia posizione: un corpo di donna, cisgender, bianco — quindi, tutto sommato, abbastanza privilegiato nella sfera pubblica. In quella partitura ho lavorato sul rapporto tra visibilità e invisibilità, tra silenzio e risonanza, in relazione al genere e alla presenza nella sfera pubblica — soprattutto notturna, che è ancora un tempo-spazio da riattraversare, da riappropriare. Da lì è nata anche una seconda partitura, e a un certo punto queste due sono diventate la base per esperienze più collettive. In origine erano pensate per una persona sola, che si muove da sola, di notte, nello spazio pubblico. Poi sono diventate l’occasione per camminate condivise, attivate insieme, anche a partire da partiture di altre artiste come Pauline Oliveros8 o il collettivo indiano Blank Noise9, che lavora da una prospettiva più militante. L’obiettivo è sempre lo stesso: riflettere su come camminiamo, su come i nostri corpi risuonano — e possono risuonare — nello spazio pubblico.
CAROLA HAUPT Credo che l’elemento importante che emerge sia proprio l’impossibilità di negare la dimensione politica e sociale della nostra posizionalità — soprattutto nella definizione dello spazio che attraversiamo, con pratiche di ascolto o pratiche sonore. E qui mi ricollego di nuovo a Nicola, perché l’elemento del come viene costruito lo spazio urbano — e l’idea che questo processo abbia sempre una dimensione politica e culturale — per me è centrale. Ci sono connessioni politiche, culturali, simboliche, che spesso, quando si parla di pratiche di ascolto, si tendono a dimenticare, come se fossero qualcosa di “neutro”, di separato. Ma non è così. Queste pratiche sono profondamente immerse nel contesto. E anche nell’aspetto collettivo: il modo in cui ascoltiamo — individualmente o collettivamente — contribuisce a definire lo spazio. E quindi ti vorrei chiedere: come entra, per te, tutto questo — la dimensione culturale, sociale, politica — nella lettura e nella possibile costruzione dello spazio?
NICOLA DI CROCE È una domanda che apre tantissime prospettive, tantissime riflessioni. Forse mi aggancio subito a qualcosa che mi è venuto in mente ascoltando Elena: credo che una cosa che ci accomuna — anche se con strumenti e metodi diversi — sia una certa dimensione partecipativa e attivante. Lavoriamo su pratiche e ricerche che hanno l’obiettivo di attivare una consapevolezza sonora. E questa consapevolezza fa parte di una consapevolezza più ampia: quella del nostro essere qui, del nostro stare nel mondo, del riconoscere, ad esempio, il passaporto che abbiamo… e così via.
È una consapevolezza che passa anche attraverso l’ascolto attivo. Credo che situazioni come questa mostra, e come molte altre, possano contribuire a formare soggetti che non solo pensano, ma sanno anche ascoltare criticamente. E questo tipo di consapevolezza sonora può trasformare le relazioni, i comportamenti, il modo in cui stiamo nello spazio pubblico e, più in generale, nella società. Ci sono molte prevaricazioni sonore di cui spesso non ci rendiamo conto. Ma riconoscerle, nominarle, può essere molto importante, perché ci aiuta a capire come stiamo al mondo. In tutto questo, la partecipazione è fondamentale.Un primo passaggio è sicuramente individuale: la consapevolezza parte dal singolo. Ma è quando questa consapevolezza diventa collettiva che può produrre un impatto reale.E penso che il lavoro di Elena vada proprio in questa direzione: cercare una maturazione collettiva di questa consapevolezza.Che significa anche, banalmente, ascoltare insieme delle cose. Anche cose molto semplici, molto quotidiane, che forse ci stiamo dimenticando.Un po’ come quando si ascoltava un radiodramma in salotto, in venti persone, perché c’era solo una radio. E quella situazione generava una coralità dell’ascolto, che in qualche modo oggi si sta perdendo. Perché c’è sempre più isolamento, e questa tendenza a separarsi, a evitare il confronto.Tutto questo per dire che: collettivizzare l’ascolto è importante.
CAROLA HAUPT Ora, forse sembrano tutte banalità già dette. Ma in realtà credo che siano elementi importanti — e legati anche a questa mostra. Il fatto di tornare a ricordarli, anche perché è qualcosa che cerco di fare nella mia pratica, diventa un modo per non darli per scontati, per trovare strategie diverse da quelle che normalmente mettiamo in atto.
In questo senso, Leandro, torno da te. Vorrei ricollegarmi anche al Manifesto del Futurismo Rurale 10, perché proprio questi temi — la condivisione, gli elementi collettivi — diventano centrali nella costruzione di immaginari possibili, di scenari possibili. Mi piacerebbe affrontare il tema della costruzione di dinamiche politiche e sociali attraverso le pratiche di ascolto — e attraverso le sfide, anche simboliche e culturali, che queste pongono. Come possono essere create modalità differenti di costruzione e abitazione dello spazio? Se potessi guidarci attraverso l’idea del Manifesto del Futurismo Rurale, sarebbe un bel modo per chiudere.
LEANDRO PISANO Parto da un po’ più lontano, ricollegandomi anche a quello che dicevano prima Elena e Nicola. La questione del posizionamento — e, aggiungerei, del riposizionamento — rispetto alle dinamiche di potere che regolano chi parla e chi ascolta, è stata centrale anche nel percorso che ha portato alla scrittura del Manifesto del Futurismo Rurale. Il Manifesto è stato redatto da me insieme a Beatrice Ferrara, ma rappresenta l’esito finale di un processo collettivo: un percorso di ascolto, condivisione e confronto con artisti, curatori, abitanti temporanei e stabili dei territori rurali che abbiamo attraversato con il progetto Liminaria. È stato un processo che ci ha portato a riflettere sul privilegio, sulla subalternità, sulle gerarchie implicite nei contesti in cui operiamo. Chi ha la parola? Chi ha il diritto di essere ascoltato? E come si possono rimettere in discussione queste asimmetrie? Abbiamo cercato, per quanto possibile, di creare uno spazio in cui anche chi normalmente non ha voce potesse intervenire, potesse lasciare tracce. Una questione fondamentale, che ho sentito in modo forte anche personalmente, è legata alle ragioni per cui ci muoviamo in certi spazi, e non in altri.
È una domanda che mi sono posto spesso, soprattutto negli ultimi anni, mentre portavo avanti una ricerca — che spero presto possa vedere la luce — in dialogo con pratiche sonore dell’America Latina.
Parlando con curatori, artisti e attivisti boliviani, messicani e peruviani, mi sono chiesto: quali sono le motivazioni che ci spingono a operare in contesti che non ci appartengono? Quali sono le implicazioni, anche politiche, del nostro posizionamento in quei luoghi? Questo interrogativo ha attraversato anche il lavoro sul Manifesto, che nasce proprio da esperienze di attraversamento: territori abitati da noi in forma temporanea, come membri di comunità effimere. Credo che una possibile decostruzione di certi atteggiamenti coloniali possa partire proprio da qui. Condivido molto quello che scrive Lucia Farinati nel saggio The Force of Listening 11: l’idea che il soggetto della ricerca debba essere considerato co-agente del processo, non semplicemente oggetto. Non si tratta di fare per, ma di fare con. È questa, credo, una via per costruire un terreno di solidarietà, là dove è possibile, tenendo conto delle situazioni specifiche, delle tensioni, dei conflitti. Come dice Susan Bickford12, si tratta di “ascoltare all’intersezione”. Credo che questa sia una prospettiva importante, oggi.
CAROLA HAUPT Mi hai dato il gancio perfetto per chiudere il cerchio. L’idea del co-agente — del fare con, dell’ascoltare con, del cercare con — è una prospettiva che sento molto vicina, ed è anche al centro di molte pratiche che mettono al centro l’ascolto.
Parliamo di un ascolto che non è mai passivo, ma che costruisce: costruisce relazione, produce significato, apre possibilità. È un ascolto che trasforma chi ascolta in parte attiva del racconto.
Credo che le esperienze — artistiche o quotidiane — si definiscano proprio in questo: nella relazione tra le pratiche e chi le attraversa, nei percorsi di senso che ognuno costruisce, singolarmente o in modo collettivo.
1 Traslazioni sonore. Muoversi negli spazi acustici della contemporaneità post-digitale è un articolo di Leandro Pisano pubblicato nel 2017 nel numero 14 della rivista Im@go. Studi di cinema e media, edita da Bulzoni. Il saggio esplora le pratiche sonore critiche nel contesto post-digitale, con particolare attenzione al concetto di ascolto nomadico.
2 Budhaditya Chattopadhyay è un compositore e studioso indiano. Nel libro The Nomadic Listener (Errant Bodies Press, 2020) introduce il concetto di sonic nomadism attraverso la figura dell’“ascoltatore nomade”. L’ascolto, in questo caso, si configura come pratica in movimento: il fruitore sonoro attraversa luoghi diversi e interagisce con essi in modo transitorio, sovrapponendo ambienti e percezioni. Chattopadhyay si definisce un “nomade sonoro”, la cui percezione auditiva di appartenenza è fleeting and transitory, cioè fugace e in continuo divenire. Il nomadismo sonoro implica che l’atto di ascoltare diventa un modo di navigare tra ambienti differenti, attivando pensieri e ricordi mentre i suoni connettono spazi lontani.
3 Anna Raimondo (nata a Caserta nel 1981) è un'artista e ricercatrice che lavora con pratiche partecipative, performance e sound art. La sua ricerca esplora le relazioni tra genere, voce e spazio pubblico attraverso l'ascolto. Ha conseguito un Master in Sound Arts presso il London College of Communication (University of the Arts London) e sta svolgendo un dottorato di ricerca tra l'Académie Royale des Beaux-Arts (ARBA) e l'Université Libre de Bruxelles (ULB), focalizzandosi su prospettive di genere e geografia urbana. È co-fondatrice della piattaforma Saout Radio, dedicata all'arte sonora e radiofonica. Ha collaborato a più riprese con Elena Biserna in progetti dedicati all’ascolto situato e alle politiche della voce nello spazio urbano.
4 Donna Haraway è una filosofa e teorica femminista statunitense. Nel suo saggio del 1988, Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, ha introdotto il concetto di saperi situati. Con questa espressione, Haraway sostiene che ogni conoscenza è posizionata: non esiste uno sguardo neutrale o “da nessun luogo”, poiché ogni osservatore parla da una determinata posizione sociale, culturale e corporea. Riconoscere la positionality significa dunque ammettere i propri limiti e il proprio punto di vista situato. Questo approccio evidenzia come dietro la pretesa di oggettività spesso si celi quello che Haraway chiama il “trucco del dio” (god trick), ovvero la prospettiva onnisciente che in realtà riflette il punto di vista di soggetti dominanti. I saperi situati propongono invece un’oggettività parziale e responsabile, consapevole delle posizioni di privilegio e oppressione da cui si produce conoscenza.
5Brandon LaBelle è un artista, scrittore e teorico statunitense, noto per i suoi contributi nel campo della sound art e degli studi sul suono. Nel suo libro Background Noise: Perspectives on Sound Art (Continuum, 2006), LaBelle esplora la natura intrinsecamente relazionale del suono, affermando che esso esiste solo nella relazione tra un'emissione e un ascolto.Questo principio è alla base delle Transmission Arts, un ambito artistico dedicato alle pratiche di trasmissione (radio, onde elettromagnetiche, ecc.), in cui opera e significato emergono dall'interazione dinamica tra trasmettitore e ricevente. Per un approfondimento su questo tema, si veda anche Transmission Arts: Artists and Airwaves (PAJ Publications, 2011), a cura di Galen Joseph-Hunter, Penny Duff e Maria Papadomanolaki.
6 Il termine Transmission Arts si riferisce a pratiche artistiche che utilizzano la trasmissione del suono come mezzo espressivo, indagando le relazioni tra trasmettitore e ricevente. Include performance radiofoniche, arte relazionale, installazioni sonore e sperimentazioni sullo spettro elettromagnetico.
7 La collezione a cui fa riferimento Elena Biserna è il volume Walking from Scores (Les Presses du réel, 2022), che raccoglie circa 100 partiture testuali e grafiche dedicate al camminare e all’ascolto, create da oltre sessanta artistə dal periodo Fluxus degli anni ’60 fino a oggi. Le partiture, suddivise in tre sezioni — “Walking”, “Itinerant Listening” e “Playing on the Move” — offrono istruzioni per eseguire camminate e azioni sonore nello spazio urbano, esplorando il confine tra arte e vita quotidiana. Il progetto evidenzia come il gesto del camminare possa essere letto come un modo di “leggere e riscrivere lo spazio”, proponendo un’oggettività parziale e responsabile, consapevole delle posizioni di privilegio e oppressione da cui si produce conoscenza.
8 Pauline Oliveros (1932–2016) è stata una compositrice, performer e teorica statunitense, figura centrale nella musica sperimentale del secondo Novecento. Ha elaborato il concetto di Deep Listening, una pratica di ascolto attivo e consapevole che integra corpo, spazio e ambiente sonoro.
9 Blank Noise è un collettivo artistico e attivista fondato a Bangalore, India, nel 2003 da Jasmeen Patheja. Il progetto si concentra sulla lotta contro la violenza di genere e la percezione della sicurezza nello spazio pubblico, attraverso azioni partecipative, performance e pratiche di ascolto e racconto.
10 Il Manifesto del Futurismo Rurale è un documento programmatico concepito da Leandro Pisano e Beatrice Ferrara per ripensare criticamente il rapporto tra ruralità, arte e tecnologie. Presentato nel 2019 al termine del progetto quinquennale Liminaria, il manifesto propone di considerare le aree rurali non come luoghi marginali o anacronistici, ma come spazi dinamici e in trasformazione, capaci di generare nuove narrazioni attraverso pratiche artistiche e tecnoculturali. Ispirandosi ai futurismi postcoloniali, come l’Afrofuturismo, il documento invita a superare i cliché che oppongono città e campagna, promuovendo una visione del rurale come laboratorio di sperimentazione e resistenza culturale. Il manifesto è disponibile online in italiano e inglese e ha avuto risonanza in contesti internazionali di arte e design.
11 Lucia Farinati è una scrittrice, curatrice e attivista italiana. In collaborazione con Claudia Firth, ha pubblicato The Force of Listening (Errant Bodies Press, 2017), un saggio in forma di dialogo che esplora il valore politico dell’ascolto. Il libro si basa su conversazioni con artisti, attivisti e pensatori politici, affrontando temi come la collettività, la solidarietà, la risonanza, la politica della voce e l’etica dell’ascolto. Le autrici propongono un approccio all’ascolto collaborativo e attivo, in cui il soggetto della ricerca o dell’azione partecipata è considerato un co-agente del processo, piuttosto che un oggetto passivo. Questo implica un passaggio dal “fare per” al “fare con” gli altri, costruendo insieme significato e azione. Il libro è stato riconosciuto per il suo contributo alla comprensione del ruolo dell’ascolto nell’intersezione tra arte contemporanea e attivismo.
12 Susan Bickford è una politologa statunitense. Nel suo libro The Dissonance of Democracy: Listening, Conflict, and Citizenship (Cornell University Press, 1996), esamina il ruolo dell'ascolto nel processo democratico, evidenziando l'importanza di un ascolto attivo nei punti in cui si intersecano differenze e conflitti sociali. Bickford sostiene che la cittadinanza democratica richiede l'ascolto delle voci provenienti da prospettive diverse, promuovendo così un confronto che, accogliendo dissonanze e divergenze, può rafforzare la partecipazione e la giustizia in ambito politico.
Segui GOLEM su Instagram:
Ascolta CHIACCHIERE, il podcast di GOLEM su Fango Radio
IL DISCO DEL MESE
Aunes - Judith Hamann (Shelter Press)
Aunes è il nuovo lavoro solista della violoncellista e compositrice australiana Judith Hamann, una raccolta di sei brani realizzati tra diversi paesi e momenti della sua vita itinerante. Il disco intreccia violoncello, voce, registrazioni ambientali, sintetizzatori e organo, sviluppando un linguaggio sonoro intimo e materico.
ISCRIVITI E CONSIGLIA GOLEM
UMIDO - Suoni a bassa durata
di Pietro Michi
La riduzione ci circonda: processori e hard disk sono passati dall’essere grandi quanto una stanza al poter sparire nel buco della tasca destra dei pantaloni. E mentre la polarizzazione tra i Big Mac sempre più grossi e i contenuti d’intrattenimento e d’informazione sempre più piccoli si fa più netta, nasce Miniature Records. Un’etichetta che ci ricorda quanto la nostra soglia d’attenzione fatica a superare un reel più lungo di 20 secondi.
Miniature Records è un progetto italiano, fondato da Riccardo Ancona nel 2022. Sul Bandcamp dell’etichetta troviamo un muro di colori diversi, ognuno dei quali racchiude un album digitale pieno di piccoli suoni. L’idea alla base dell’etichetta è proporre album composti esclusivamente da brani con una durata inferiore al minuto; vere e proprie miniature sonore, con una forte connotazione digitale, laptop music.
-Small data is beautiful. It has an intrinsic chaotic potential-
L’arte di dipingere miniature richiede precisione, pazienza, pennelli sottili e attenzione ai dettagli. Ci si può dedicare a rendere estremamente dettagliato un singolo pezzo, oppure puntare sull’impatto dell’effetto complessivo. Lo stesso accade con il suono: anche le composizioni più brevi possono contenere mondi. Ed è proprio per approfondire questo tema che abbiamo deciso di fare quattro chiacchiere con Riccardo Ancona, per farci raccontare la sua visione, il progetto e la poetica dietro Miniature Records.
Ciao, grazie per aver accettato l’invito. Ti va di iniziare raccontandoci chi sei e com’è nato Miniature Records?
Fino a un anno fa ti avrei detto che sono un sound artist; adesso la mia attività primaria è la ricerca musicologica. Mi occupo di pratiche musicali algoritmiche dal punto di vista estetico e sociotecnico. Miniature Records è un passion project, nato come esperimento sull’effetto di tracce brevi nell’ecosistema delle piattaforme di streaming, ma ha poi assunto una sua autonomia artistica ed è diventato un canale di sperimentazione per un formato espressivo estremo.
Mentre mi perdevo tra le varie uscite del catalogo, non avevo idea di chi ci fosse dietro il progetto. Quando ho scoperto che eri tu a tirare le corde, e sapendo già dei tuoi lavori sulla musica algoritmica, mi sono chiesto: è possibile che abbia ascoltato solo musica algoritmica, dal primo all'ultimo brano?
Questa pratica è fondamentale per l’identità di Miniature Records, o il concetto di “laptop music” può estendersi anche ad altri mezzi compositivi?
Trovo che la collezione di Miniature sia un formato ideale per quelle composizioni algoritmiche che presentano poca varietà sonora interna, ma mostrano molte sfumature al variare delle condizioni di partenza. Ogni miniatura manifesta immediatamente uno stato possibile e singolare del sistema, pur mantenendo una Gestalt coerente con le altre. C’è poco spazio altrove per questa musica, quindi tendo a essere selettivo e mantenere una linea estetica delimitata. Alcuni lavori sono meno algoritmici di altri, ma presentano sempre una natura processuale intelligibile all’ascolto.
Quando dialoghi con gli artisti che hanno pubblicato per Miniature Records, emergono mai racconti di stimoli particolari o difficoltà legate a queste forti limitazioni? Hai qualche aneddoto da condividere?
La radicalità del formato è una sfida e uno stimolo, che spesso porta gli artisti a imporsi ulteriori limitazioni. C’è chi decide di concentrarsi su fenomeni acustici limitatissimi:
chi compone ciascun brano con una sola riga di codice:
ma anche chi programma un intero sistema generativo pensato appositamente per creare miniature:
Talvolta ci vuole più tempo per calibrare questo genere di processi che per comporre un doppio LP.
Ho trovato il vostro manifesto molto conciso (come d’altronde ci si potrebbe aspettare):
- Brevity is elegant.
- The contemporary age has a short attention span. We need to adapt our minds to briefness.
- Small data is beautiful. It has an intrinsic chaotic potential.
Mi interessa particolarmente il concetto di eleganza correlato alla brevità, e il potenziale caotico degli small data. I virus, sono davvero caos o sono solo un altro tipo di ordine?
Non si tratta solo di minimalismo: oggi ogni suono è tecnicamente imitabile, purché vi siano abbastanza megabyte di audio per addestrarci una rete neurale. Resta fuori solo ciò che sta al di sotto della soglia minima di dati per l’inferenza. Lo small data non è generalizzabile, e quindi non può essere sfruttato; poiché eccede la norma statistica, ma non è rumore, probabilmente è caos. Inoltre, non è cronofago né energivoro. Mentre gli ingegneri delle big tech si preoccupano di inventare modelli universalizzanti costruiti con milioni di brani rubati che non hanno mai ascoltato, a me, come ad altri artisti algoritmici, interessa lavorare su poco materiale, ma che sia curato e che racconti qualcosa del nostro modo di vedere il mondo.
Si dice che i pesci rossi abbiano una memoria di appena 10 secondi (fake news). Se questa fosse una condizione globale, pensi che, oltre a ridurre la durata dei brani, si dovrebbe anche intrecciare la narrazione musicale? Inserendo richiami e rimandi continui, in modo che anche chi si è già dimenticato cosa è successo 10 secondi fa possa comunque seguire e godere dell’opera nel suo insieme?
Penso che, a quel punto, sarebbe meglio rinunciare alla narrazione. Soltanto alcuni discorsi musicali si prestano a intervalli di tempo così brevi. Provate a comporre un brano ambient da 10 secondi: ne verrà fuori un sound logo, senza possibilità di trascendenza.
La musica di Miniature Recs si presta a durate brevissime soltanto perché è la materializzazione contingente di strutture matematiche di per sé atemporali: il che implica che quello che si ascolta non è mai l’opera nel suo insieme, ma soltanto una delle possibili.
Prima di salutarci, ci consigli due brani?
Uno dal catalogo di Miniature Records, e uno molto lungo, almeno 20 minuti, che ti piace particolarmente.
Edith Dahl – Elm Kfral
Georg Friedrich Haas – In vain (nell’esecuzione del Klangforum Wien del 2003)