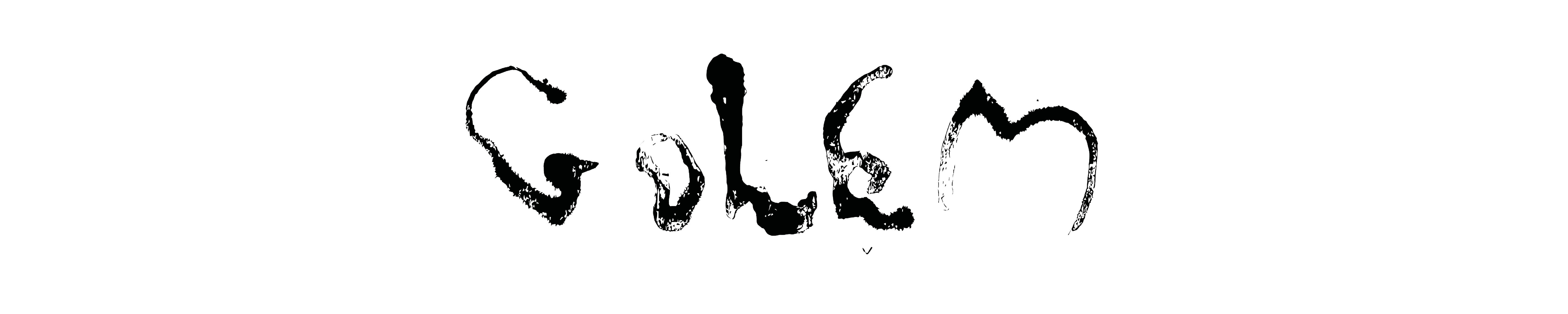Intervista ad Ansis Bētiņš e Artūrs Čukurs
di Matteo Mannocci
Ansis Bētiņš e Artūrs Čukurs sono un duo vocale lettone, che si muove con naturalezza tra mondi sonori diversi, dal folk alle musiche antiche fino alla contemporanea. Il loro approccio è guidato da una profonda curiosità verso le tradizioni vocali di epoche, luoghi e culture differenti, che rielaborano con una sensibilità personale e un rigoroso senso della ricerca.
Il 17 Gennaio 2025 è uscito per l’etichetta svedese XKatedral il loro disco “Slavic Folk Songs”, una raccolta di brani popolari provenienti in gran parte dall’Ucraina e da vari paesi slavi.
Dunque, prima di tutto, com'è iniziato questo progetto? Ho letto che avete trovato tutti questi archivi online sulla musica popolare ucraina. Ma avevate mai lavorato prima con questo tipo di repertorio?
[Ansis Bētiņš] Come hai letto nelle note del disco, io studiavo musica antica e, prima ancora, ho studiato canto lirico, ma mai musica folk. Né io né Artur abbiamo mai studiato musicologia o canto tradizionale. È stato solo un caso fortunato il fatto che ci siamo imbattuti in questa musica e in questo modo di cantare. E sì, ci siamo semplicemente detti che potevamo provare anche noi, fare un tentativo. Non ci saremmo mai aspettati che tutto questo si sarebbe trasformato in un album e in un tour con un repertorio simile.
Per quanto mi riguarda – Artur potrà raccontare la sua versione – continuo a esibirmi come cantante di musica antica, e questo progetto, quello dei canti popolari slavi, è qualcosa che faccio un po' di lato. È un progetto parallelo, ma sempre di più sta diventando qualcosa di più grande, più stabile e quasi prioritario. Sta iniziando a essere una delle cose più importanti nella mia vita professionale come musicista.
[Artūrs Čukurs] Anche se non l’abbiamo fatto prima, la musica e il canto popolare fanno parte della nostra cultura, sono essenziali, e penso che siano sempre stati presenti nella nostra vita, fin dalla nascita. Quindi, in un certo senso, è come se lo avessimo fatto per tutta la vita.
E dopo aver lavorato a questo repertorio, mi verrebbe da dire ‘pan-slavo’, pensate di aver ritrovato qualcosa -forme, strutture…- nella musica prodotta oggi?
[Ansis Bētiņš] Beh, non ho visto davvero niente di simile di recente. Da noi abbiamo una grande tradizione corale, una tradizione di canto corale molto forte. Quindi ci sono alcuni compositori che continuano a usare la musica folk come fonte di ispirazione per le loro composizioni. Ma non direi che sia ancora una tendenza, soprattutto per quanto riguarda i canti popolari slavi. Possiamo vedere qualche influenza, o almeno qualche idea presa forse dalla musica folk ucraina, ma non dalla regione pan-slava in generale.
Penso che l'idea, o meglio la visione, almeno dal punto di vista della Lettonia — dal nostro punto di vista, dalla Lettonia — sia che stiamo sostenendo l'Ucraina in ogni modo possibile. Quindi non ho visto né sentito parlare di composizioni influenzate, non so, dalla musica folk russa o bielorussa o qualcosa del genere.
[Artūrs Čukurs] Ma intendi nella musica lettone, o nella musica che viene fatta in Lettonia, o in generale? Perché penso che ci sia un grande revival della musica folk anche in Ucraina. Ad esempio, c’è una band molto conosciuta, i DakhaBrakha, che crea nuovi brani ispirandosi proprio al loro folklore. E fanno questo genere di folk pop... o non so nemmeno bene come definirlo in modo corretto... comunque, quello succede già da molto tempo.
Però, sì, penso che sia un po’ complicato... quando chiedi del mondo pan-slavo, credo sia difficile parlare di tutta la regione slava come di qualcosa di unitario, perché è molto variegata. E penso che, sì, la situazione sia molto diversa in ogni sua parte. Quindi è problematico anche solo cercare di vedere la regione pan-slava come qualcosa di unificato al giorno d’oggi, direi.
Per l’appunto: avete trovato invece qualcosa che unisce le musiche degli Slavi del sud e del nord?
[Ansis Bētiņš] Direi che ci sono più differenze che somiglianze. Beh, le lingue, almeno dal mio punto di vista, sembrano simili. Suonano simili. Riesco sicuramente a vedere il legame tra loro, visto che le lingue slave appartengono allo stesso ramo dell’albero linguistico. Ma per quanto riguarda la melodia, il modo in cui queste canzoni vengono cantate, il modo in cui il suono viene prodotto e i diversi tipi di ornamentazioni che si trovano in queste musiche, in questi canti popolari, ci sono molte differenze.
Voglio dire, i paesi slavi del sud sono stati fortemente influenzati dall’Impero Ottomano per generazioni, per centinaia di anni, quindi il loro suono ha un carattere più orientale, mediorientale, si potrebbe dire. E anche il tono è spesso più nasale. C’è un uso molto più ampio delle ornamentazioni all’interno di queste canzoni.
Ma nella parte settentrionale, nei paesi slavi del nord, o meglio ancora negli slavi orientali, le cose sono diverse. Noi lo chiamiamo — forse lo hai già sentito nella nostra descrizione — il canto "a voce bianca". È un canto che non usa la risonanza della testa, non c’è amplificazione nei risuonatori superiori. È semplicemente un suono puro, "bianco", che esce direttamente dalla gola.
Questa è una delle differenze principali tra il nord e il sud. Anche se a volte ci sono sovrapposizioni. Ci sono molte somiglianze nei temi trattati: che si parli di matrimoni, di amore, di nostalgia o di canzoni sulla natura, troviamo spesso motivi ricorrenti. Ci sono molte canzoni, ad esempio, che parlano della nebbia, di fitte nebbie in cui si scorge un grande albero e, vicino a quest’albero, c’è un pozzo o qualcuno che aspetta un amato, o spera che qualcuno arrivi.
Quindi sì, ci sono alcune somiglianze nei temi, ma il modo in cui queste canzoni vengono cantate, la tecnica vocale, il modo in cui viene prodotto il suono... lì si vede chiaramente la differenza.
Una domanda sul vostro processo: come avete trovato le musiche negli archivi? Era tutte registrazioni oppure avete trovato anche degli spartiti?
[Ansis Bētiņš] Nessuno spartito. Fondamentalmente usiamo field recording come materiale di riferimento e poi trascriviamo la musica da queste registrazioni, arrangiando le melodie per due voci. Perché la maggior parte di queste è o monodica, quindi con una sola linea melodica, oppure, al contrario, pensata per un ensemble molto più ampio, anche fino a otto voci. Quindi dobbiamo adattarle e arrangiarle per due voci.
E siete stati fedeli alle tecniche del canto che avete trovato?
[Ansis Bētiņš] Tendiamo a non allontanarci troppo da quello che è il suono originale, da come si ascolta nelle registrazioni. Perché, sì, come abbiamo già detto prima, non siamo cantanti folk professionalmente formati. Quindi ci affidiamo a queste registrazioni, convinti che rappresentino il modo in cui queste canzoni dovrebbero essere cantate, e per questo ci atteniamo a quello.
Voglio dire, già il fatto che stiamo arrangiando queste canzoni per due voci, per le nostre voci, è di per sé qualcosa di diverso rispetto a ciò che sentiamo in quelle registrazioni di campo. E anche il fatto che non siamo formati come musicologi o cantanti folk contribuisce a creare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, fondamentalmente.
Quando studiavo etnomusicologia, trovavo incredibile il lavoro di Alan Lomax e Diego Carpitella, qui in Italia, che negli anni ’50 registrarono ogni tipo di musica popolare italiana in un Paese appena uscito dalla guerra. Così riuscirono a creare un’immagine di una nazione, con tutte le sue sfumature, differenze e forti identità. E oggi è facile studiare tutto questo, perché esiste questo enorme archivio ordinato di registrazioni sul campo, etnografie e scritti. Avete trovato qualcosa di simile nella vostra ricerca?
[Ansis Bētiņš] Non proprio. Gli archivi che abbiamo utilizzato per il nostro repertorio, come è scritto anche nelle nostre note di copertina, sono emersi subito dopo che la Russia ha iniziato la sua guerra su vasta scala in Ucraina. E questi archivi vengono chiaramente usati come uno strumento per cercare di salvare le tradizioni e il patrimonio popolare delle regioni dell'Ucraina che attualmente sono occupate dalla Russia.
Quindi, questi archivi di registrazioni non sono qualcosa di particolarmente organizzato o omogeneo. Anzi, sono piuttosto caotici, ed è anche per questo che abbiamo dovuto fare un lavoro abbastanza impegnativo per ascoltarle tutte e trascriverle. Il nostro metodo per trovare il repertorio e la musica che ci interessava è stato semplicemente scorrere lentamente tutti gli archivi, ascoltare attentamente le registrazioni e poi decidere se a entrambi piaceva il modo in cui suonava la melodia, se trovavamo qualcosa di specifico o abbastanza interessante in quella melodia o nel tema, tanto da volerla cantare e portare nei nostri concerti.
A volte magari era un suono diverso, un ritmo particolare che emergeva. Anche l'Ucraina stessa non è un paese omogeneo: abbiamo notato che la parte orientale, il folklore dell’est, e la parte occidentale, vicino ai confini con la Romania e l'Ungheria, presentano differenze notevoli. E questo si percepisce chiaramente nella musica e nei materiali che abbiamo trovato.
Quindi, per rispondere alla tua domanda, no, gli archivi non sono omogenei. E in realtà non abbiamo nemmeno trovato informazioni precise su chi li abbia creati, chi siano gli autori di queste raccolte. Però sappiamo che le registrazioni più antiche che abbiamo trovato risalgono agli anni '80, ai tempi dell'Unione Sovietica. E poi ce ne sono molte altre fatte negli anni '90 e nei primi anni 2000. Sembra che qualcuno avesse già queste registrazioni, ma non fossero ancora state digitalizzate. Per noi è stato davvero molto utile e importante averle trovate in questa forma, perché ci hanno dato la possibilità di costruire il nostro repertorio.
Mi riferivo al lavoro di Lomax e Carpitella anche perchè, negli anni, l’utilizzo delle musiche popolari italiane ha assunto un valore politico di resistenza. Da parte vostra c’era l’intenzione di fare una sorta di dichiarazione politica?
[Artūrs Čukurs] Non lo so, non è mai stato per noi una dichiarazione politica fin dall'inizio. Direi che abbiamo semplicemente incontrato questa musica e, in sostanza, ci è piaciuta e abbiamo voluto condividerla. Questa è la verità, tutto qui. Ma, ovviamente, il contesto contemporaneo la rende anche una questione politica, direi.
E sì, non so... abbiamo discusso alcune scelte che facciamo riguardo alle canzoni che cantiamo, su quale canzone si adatti o quale canzone ci sembra appropriata, oppure quale forse adesso non è il caso di cantare. Però, l'origine di tutto, il motivo iniziale, è stato semplicemente la bellezza di questa musica e il nostro desiderio di condividerla.
Per quanto riguarda i live, che tipo di reazioni avete incontrato? Avete forse avuto critiche per il modo in cui avete interpretato le musiche?
[Ansis Bētiņš] Non abbiamo mai incontrato nessuno che fosse in disaccordo con le nostre scelte o che ci dicesse che non è appropriato il modo in cui eseguiamo queste canzoni. Abbiamo suonato molte volte, anche per rifugiati ucraini, e loro sono particolarmente toccati e contenti che cantiamo canzoni ucraine, specialmente in questo periodo. La reazione è sempre stata molto calorosa e accogliente. Anzi, spesso ci chiedono di includere alcune delle loro canzoni preferite nel nostro repertorio. A volte vengono da noi e ci domandano: "Potreste aggiungere questa o quella canzone?”. Quindi sì, le reazioni sono sempre state davvero molto positive e accoglienti. Non abbiamo mai incontrato critiche forti o disaccordi su come facciamo quello che facciamo e su come ci esibiamo.
[Artūrs Čukurs] E volevo anche aggiungere che il nostro pubblico è molto vario, ed è stata una sorpresa per noi scoprire che persone con gusti musicali molto diversi ci ascoltano. Diciamo che ci sono persone che amano la musica folk, altri che amano la musica classica, e anche ascoltatori di musica d’avanguardia tra il nostro pubblico. Ed è ancora sorprendente per noi, anche in termini di età: ci sono persone molto giovani e altre molto anziane. Questo tipo di musica, sorprendentemente, riesce a parlare a molte persone, di età e nazionalità diverse.
Quindi sì, penso che abbia qualcosa a che fare con il materiale stesso, che in qualche modo riesce a comunicare. Non direi "universalmente", ma c’è sicuramente qualcosa che permette a molte persone di ritrovarsi in questa musica.
Questa domanda è particolarmente indirizzata ad Ansis, che so aver studiato early music in Italia. Che differenze hai notato nella musica vocale e sacra tra l’Europa occidentale e orientale?
[Ansis Bētiņš] Mi sono documentato su questo e posso dire, quasi con certezza, che c’è stata una forte influenza del Rinascimento italiano, del primo Rinascimento e anche del Barocco, nella musica sacra ucraina. Ho cantato anch’io molta musica sacra ucraina, canti sacri per ensemble vocali maschili, del primo periodo barocco, e in quell’epoca molti strumentisti e insegnanti italiani vivevano nella Polonia settentrionale e in Lituania, soprattutto a Vilnius. E molti musicisti e compositori ucraini studiavano proprio lì. Quindi c’è quasi la certezza che si siano incontrati, e la musica stessa, la melodia, il modo in cui le composizioni sono scritte e come suonano, e il modo in cui si sviluppano le armonie, è molto simile a quello che facevano gli italiani in quel periodo.
In particolare posso citare Nikolay Diletsky, che è un compositore ucraino molto conosciuto del periodo barocco. Lui ha composizioni per ensemble vocali che somigliano alle composizioni che venivano create in quel periodo in Italia. E, tornando al nostro programma, al progetto che io e Arthurs stiamo portando avanti abbiamo incluso anche alcuni canti sacri ucraini nel nostro repertorio, che eseguiamo a cappella. Però è noto — e possiamo trovarne conferma nei documenti scritti — che, nella maggior parte dei casi, questi canti venivano eseguiti insieme a uno strumento di accompagnamento.
Di solito si trattava di uno strumento a corde ucraino, la Bandura, in pratica è la stessa cosa delle monodie italiane accompagnate da liuto o tiorba.
Quindi sì, l’influenza delle tradizioni italiane era ben conosciuta in Ucraina.
Un’ultima domanda: avete intenzione di continuare questo progetto, magari creando un canzoniere, un’antologia?
[Ansis Bētiņš] Non ci avevo mai pensato, ma di solito molte persone ci chiedono: quante canzoni avete? E posso onestamente dire che non lo so. Abbiamo fatto così tanti concerti, con repertori sempre diversi, che in realtà non abbiamo mai contato quante di queste canzoni abbiamo davvero. Ma non so, Arthur, pensi che faremo di questo un canzoniere, un’antologia? Creeremo qualcosa del genere?
[Artūrs Čukurs] Penso che dovremo raccoglierne ancora di più, per poterla chiamare un’antologia.
Segui GOLEM su Instagram:
Ascolta CHIACCHIERE, il podcast di GOLEM su Fango Radio
IL DISCO DEL MESE
Les disparitions - SEBASTIEN ROUX (INSUB records)
Les Disparitions è una serie di studi per viola, voce, violoncello ed elettronica che indaga le molteplici forme della scomparsa del suono. Ogni brano si sviluppa attorno all'idea di dissoluzione, esplorando i confini tra presenza e assenza, materia e memoria sonora. A guidare la costruzione dei pezzi sono delle partiture verbali: testi che hanno orientato il lavoro in prova e che rappresentano l’impalcatura concettuale e performativa del progetto. Queste partiture si muovono tra indicazioni d’azione e suggestioni poetiche, descrivendo stati d’ascolto o condizioni sonore da evocare e attraversare. Il risultato è un percorso musicale che si snoda lungo i margini del percepibile, dove il suono si trasforma, si ritrae e, infine, scompare.
ISCRIVITI E CONSIGLIA GOLEM
UMIDO - HARDSUB
di Pietro Michi
L'arte del sottotitolo (SUB) è essenziale per fruire di opere cinematografiche, videoludiche e altri contenuti in lingua originale. Per ottenere un buon risultato servono una solida conoscenza della lingua e abilità nella scrittura. I sottotitoli possono essere fedeli alla traduzione vocale di un film o reinterpretati per aggiungere personalità al testo, renderlo più fluido o semplicemente più vicino al contesto originale.
Negli ultimi anni, però, i sottotitoli hanno assunto anche un nuovo ruolo, insinuandosi nella quotidianità e diventando visibili anche a chi non è appassionato di opere in lingua originale. Sui social, infatti, la maggior parte dei video, dai Reel agli Shorts, fino ai TikTok, ha dei sottotitoli. Questo accade indipendentemente dall’esigenza di comprendere la lingua: l’importante è comunicare con chi non vuole alzare il volume, non può ascoltare o, più semplicemente, si trova su un mezzo pubblico e ha il buon senso di non disturbare gli altri passeggeri.
Parliamo di HARDSUB
“nei video codificati con sottotitoli hardsub, i sottotitoli non si possono nascondere. I sottotitoli sono parte integrante dei fotogrammi del filmato“ (Wikipedia)
-Quando i sottotitoli sono intenzionalmente impressi nel video-
Può anche capitare che questi sottotitoli siano generati automaticamente o creati da utenti poco pratici, sia in termini di software che di grammatica. Non è raro leggere parole poco coese, soprattutto quando vengono usate app di sottotitolazione automatica, font privi di lettere accentate maiuscole (tra l’altro spesso particolarmente bruttini, dai…), punteggiatura assente, refusi e parole errate. E la cosa interessante è che, nella maggior parte dei casi, tutto questo viene semplicemente accettato. I video vengono caricati così, senza alcun controllo. Spesso, inoltre, il narratore non compare nel video: viene mostrato un soggetto che cattura l’attenzione, mentre gli occhi, che poverini sono solo due, devono destreggiarsi tra immagini e testi già di per sé caotici e veloci. Fa piacere notare che chi crea questi video si curi di noi, permettendoci di usufruire del contenuto nei luoghi più impervi. Ma, al tempo stesso, spesso mi sento anche un po’ sbeffeggiato dalla noncuranza con cui viene portato a termine il compito!
Forse sono io che mi lascio confondere, ma se un testo deve sostituire una narrazione parlata in un contesto visivo, allora dovrebbe essere chiaro e curato. Mi ricordo che, nel lontano 2009, quando ero ancora un pischello, provai a guardare Terminator Salvation con degli amici. Facendo affidamento ai soliti siti poco ortodossi, trovammo una versione in italiano HARDSUBBATA in russo. Alla fine della visione, avevamo tutti il mal di testa: gli occhi cadevano continuamente su quelle bellissime scritte in cirillico, come se potessero aiutarci a capire meglio, ma ci stavano solo distraendo da quello che avremmo potuto semplicemente ascoltare. Cercavamo di seguire il film, ma dopo aver perso qualche frame importante, finivamo per rincorrere la prossima frase sottotitolata, fino a innervosirci.
L’uso sempre più diffuso della comunicazione visiva non allena l’udito. Ascoltare certi video potrebbe arricchire l’esperienza, permettendo di cogliere pause, inflessioni e toni del discorso, ma tutto questo si perde in un’estrema semplificazione del messaggio. Non è una critica, è un dato di fatto. Un fatto che si inserisce perfettamente in un mondo dove il tempo è poco, gli spazi sono ridotti e la voglia scarseggia. Siamo pessimi ascoltatori.