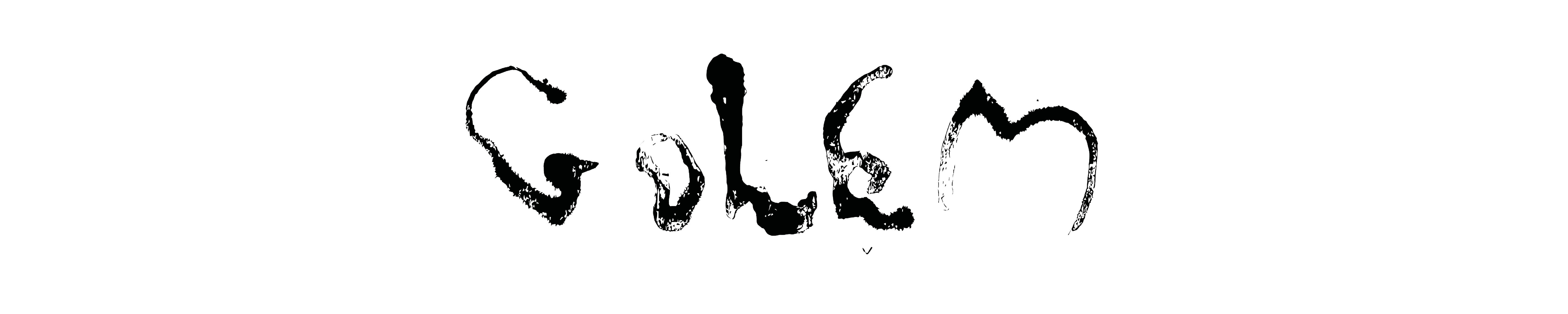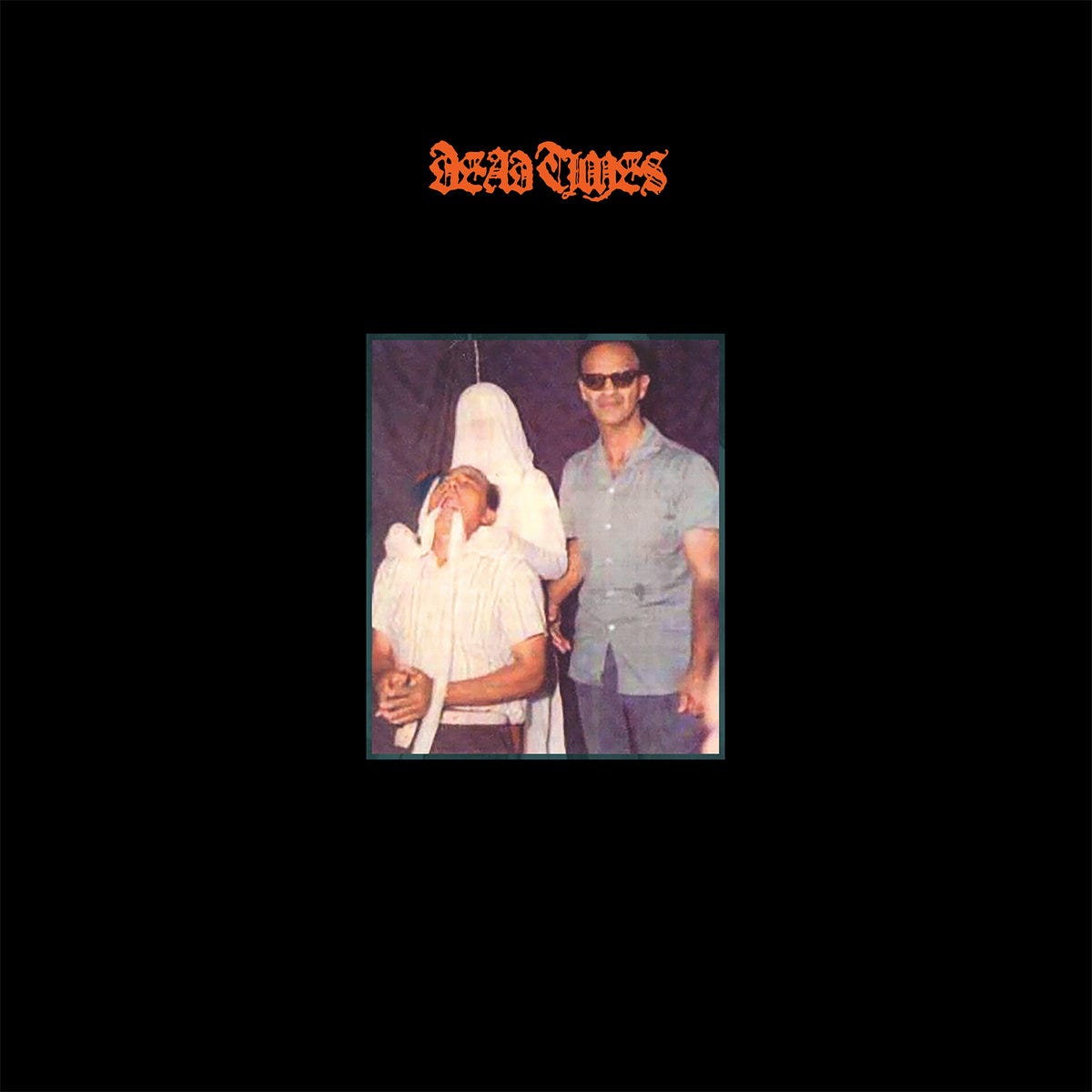Newsletter#008
Intervista a Luciano Maggiore
di Matteo Mannocci
Luciano Maggiore è un musicista e compositore siciliano di base a Londra. Nei suoi lavori, realizzati particolarmente attraverso l’utilizzo di materiali sonori pre-registrati e assemblati, ponendo l’accento sulla materialità del suono. Insieme a Louie Rice ha fondato nel 2017 NO-PA/PA-ON, progetto incentrato sull’esecuzione di partiture scritte da altri artisti e loro stessi.
Ascoltando i tuoi lavori mi viene subito da pensare al tuo uso dei materiali sonori; passi prima da lavoro di composizione con conseguente raccolta di suoni o invece parti da una serie di registrazioni già presenti nel tuo archivio? E che tipo di materiali sono quelli con cui preferisci lavorare?
Direi che entrambi i processi che descrivi possono definire il mio metodo di lavoro e che dipende molto dalla composizione.
Alle volte passo da un'idea abbozzata di composizione e raccolgo attorno a quell'idea una palette di suoni che possono o no finire all'interno del lavoro, ed alle volte viceversa inizio a investigare e creare i suoni e cercare di capire che forma vogliano prendere e che natura il loro susseguirsi o raggrupparsi mi suggerisce. Cerco di intravedere il mondo che dovrebbe ospitarli.
Ma è un discorso molto generico che potrebbe tradire se stesso e che non intendo come una regola. Ogni disco sembra avere la sua ragione di essere e le proprie procedure.
Riguardo ai materiali con cui preferisco lavorare invece non saprei proprio come rispondere. Cose che non mi sono interessate affatto per anni diventano importantissime e viceversa altre che sono state quasi sempre presenti diventano irrilevanti. Non la metterei sulle preferenze. Diciamo che cerco sempre di rispondere a delle mie necessità.
Quando cominci a lavorare su suoni registrati, sai precisamente cosa vuoi ottenere? Quanta imprevedibilità esiste nei tuoi brani, e quanto questa può arrivare a dare una direzione al lavoro?
Ne conosco delle qualità e cerco quelle qualità usando tecniche che lasciano spazio all'imprevisto. Le tecniche di lavoro però sono spesso fissate a priori, quindi il risultato è sì sorprendente ma anche in qualche modo previsto. Per farti un esempio, se scelgo di usare un meccanismo che fa muovere un certo suono da destra a sinistra, di certo so che il suono finirà il suo percorso a destra dell'immagine stereofonica e a stupirmi saranno il tempo che ci metterà ad arrivarci o i movimenti che farà tra punto A e punto B.
E questo tipo di sorprese danno decisamente una direzione al lavoro e influenzano le decisioni che prenderò volta per volta nella costruzione dei pezzi.
In molte delle tue uscite discografiche mi sembra esca fuori un tentativo di definire la realtà attraverso dei metalinguaggi musicali. Si parla molto di suono e di musica all’interno dei tuoi dischi, a volte esponendo il processo, lasciando o tagliando parte dei rumori presenti nei materiali o come nell’ultimo “necesse est numquam revelare stercorem tuum” realizzato insieme a Michael Speers in cui ‘distillate’, in un processo quasi alchemico, il nucleo del black metal, come scritto nella breve nota che accompagna l’uscita. Forse rischio di farti una domanda banale, ma pensi che la musica debba parlare di qualcosa, oltre che di sé stessa?
Sono contentissimo di questa domanda perché è la prima volta che mi si chiede del metalinguaggio nel mio lavoro!
Non so se la musica debba parlare di qualcosa oltre che di se stessa, e non sono contrario al cercare di veicolare messaggi o ancora meglio significati tramite l'arte. Non mi occupo di significati. Mi interessa il progredire delle forme e quindi un'arte per l'arte.
Con Michael Speers ci siamo trovati spesso a parlare di Metal osservando dischi che canonicamente non lo erano ma che emanavano un'aurea che ne parlava. Abbiamo passato un po' di tempo in studio a registrare chitarre distorte e falsi growling fino a trovarci a lavorare a questa cosa che probabilmente non è black metal ma che sa di black metal.
Tornando al nocciolo della tua domanda mi vien da dire che forse la musica parla sempre di musica facendo affermazioni su sé stessa. Banalmente se si sceglie di fare un disco Rock 'n' Roll si aggiunge un'altra definizione o opinione alla storia delle opinioni legate a quel genere. E mi sembra che questa affermazione possa estendersi a tutto e che sia quello che la storia dell'arte fa continuamente.
Un disco di cui sono curioso sentir raccontare qualcosa è “pietra e oggetto”, uscito nel 2020 per Kohlaas. Nel suo essere così ‘crudo’, esponendo suoni e rumori uno dopo l’altro, come accennavo sopra sembra di voler definire degli ambienti tramite uno straniamento dei sensi, conoscerli attraverso l’esperienza uditiva prima che visiva.
Pietra e oggetto è un disco che a posteriori ritengo parte di una trilogia non annunciata e di cui non ero a conoscenza di cui 9 enclosures (senufo editions) e locu (dinzu artefacts) sono le prime 2 parti.
I tre dischi sono accomunati da un uso di una paletta di suoni ridottissima ed un modo simile di usare la stereofonia e spazi in negativo. Nella mia testa i 3 lavori parlano di 3 modi di guardare lo stesso modo di organizzare il suono ma da punti di vista diversi. Sono tre vedute dello stesso pianeta.
Trovo che sia un disco psichedelico così come lo è il mio ultimo, self-talk.
Michael Speers, tornando al discorso di prima, diceva che locu era un disco Black Metal :)
A proposito di questo, riascoltando in questi giorni mi è tornata alla mente una risposta che mi diede Francesco Cavaliere qualche mese fa. Mi disse che immaginava il suo paesaggio sonoro ideale come “tutti i suoni del paesaggio in cui mi trovo con almeno 13 secondi di silenzio tra un suono e un altro, nessuna sovrapposizione sonora eccetto che per il frantumarsi del legno e il vento sulle foglie se c’è” e la ho trovata molto affine con “pietra e oggetto”. Quindi mi sento quasi obbligato a chiedere anche a te: come immagini il tuo paesaggio sonoro ideale?
Francesco è un vecchio amico e mi sento molto vicino al suo ideale di paesaggio sonoro.
Devo dire che non mi sono mai posto la domanda. Cerco luoghi di suono semplici, dove poche cose succedono ed ognuna lascia lo spazio alle altre per manifestarsi, contemporaneamente, se nello stesso ambiente. Susseguendosi, se nella stessa linea temporale.
Non sono mai riuscito a vederti dal vivo, quindi devo chiederti: quanto e come cambiano i tuoi processi di composizione ed esibizione, e in che modo si incontrano, sempre che lo facciano?
I due campi di lavoro sono totalmente diversi. Per il lavoro su disco devi tenere in conto delle cose e per quello dal vivo delle altre. Nel disco i suoni sono fissati e irremovibili. Le decisioni prese rimarranno sedimentate per sempre in quel segmento temporale senza possibilità di intervento. Ogni possibile ragionamento sull'attenzione dell'ascoltatore lascia il tempo che trova non potendo controllare il modo in cui il fruitore avrà a che fare con la composizione.
Dal vivo le cose cambiano, lavoro con delle regole ferree e spesso l'elemento performativo, per quanto minimale, ha una grossa componente compositiva. È una cifra con una presenza importante tanto quanto lo sono i suoni che verranno prodotti. La rappresentazione del suono non è più frontale ma anzi attraversa e abita lo spazio cosi come il performer e lo spettatore. La composizione dell'intervento non si muove solo su una linea temporale ma interseca varie linee spaziali, comportamentali e modi di fruire la presenza (sia quella del musicista che quella del corpo ascoltante nel momento).
I due approcci hanno livelli di difficoltà diversi. Entrambi però si nutrono del lavoro precedente e li sento permeabili l'uno con l'altro. Alle volte un live può essere l'occasione per ingrandire un elemento microscopico di un disco e viceversa. Con ognuno dei due medium posso fare cose che trovo difficili fare con l'altro. Ed entrambi gli approcci sono parte di una storia di idee che segue un filo conduttore, anche se apparentemente illegibile.
Sempre sull’aspetto live, ho recuperato tramite video e racconti alcune delle performance che insieme a Louie Rice portate avanti dal 2019 con il nome di NO-PA/PA-ON, in cui eseguite partiture vostre o di altri artisti. Qui, nel solco dell’avanguardia tardo novecentesca, e penso a Fluxus come primo riferimento, è invece fortissimo il ricorso all’azione fisica e performativa, per creare una sorta di non-musica. Quali sono gli aspetti su cui più riflettete nella selezione degli score che eseguite o quelli che componete?
Abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2017 eseguendo partiture storiche o che altri artisti scrivevano per noi. Cosa che abbiamo presto abbandonato per dare spazio ad una nostra produzione. Non si è mai fatta molta "filosofia" sul nostro lavoro insieme, usando più il gusto o l'intuizione nella scelta delle partiture o nella loro creazione.
Cose su cui negli anni abbiamo insistito sono una stereofonia netta, phasing, e una certa secchezza (dryness), tutti elementi che erano già presenti in entrambi i nostri soli e che ci hanno fatto avvicinare cercando un territorio di lavoro comune.
Segui GOLEM su Instagram:
SEGNALAZIONI - OTTOBRE ‘23
di DPK800
Cinque segnalazioni (+1) per recuperare alcuni dei momenti salienti dell’ultimo mese. Per aprire i dischi, clikka sulla copertina.
Nuovi stili di jungle/dnb, AD93 sempre a mezzo fra clubbing e ricerca (qui siamo nella prima tratta).
Naarm/Melbourne con base a Londra debutta sulla AD93 con Brake Fluid e fa ballare anche i muri.
Se vi viene in mente un incrocio fra un etnomusicologo e un ravers eccoci Julien Hairon aka Judgitzu da quando uscì un doppio singolo su NNT Umeme/Kelele, con quell’atmosfera da giungla nella notte (un po’ come in Jiumanji quando iniziavano i tamburi però in stato perenne e tu eri in uno stato di paura ed eccitazione) con Sator Arepo ci immerge ancora di più nella selva.
Al netto delle loro ultime collaborazioni quella riuscita meglio e come poterlo descrivere se non con le parole di Mohammad and Mehdi Mehrabani aka Saint Abdullah "This generation, man, we're really good at putting up walls, despite all our openness. But where does this all lead to? What exactly are we chasing? This is where I especially love the name 'Chasing Stateless,' because if all this continues, we indeed will end up stateless, society-less, community-less, neighbor-less. Just a bunch of same-sies, living in an imaginary bubble, where we all look / think / say / CHASE the same things."
Uno degli innumerevoli progetti di cui fa parte Lee Buford, una metà di The Body e Sightless Pit [per nominarvi i più conosciti] a cui ha preso parte, qui in coppia con Steven Vallot che ci masticano e sputano.
Noise/metal/elettronica
Michael Cutting+Vitalija Glovackyte duo di Manchester che si diverte a manipolare nastri, sfruttare strumenti fatti in casa e field recordings.
Postdubpostpunkpostvitæ sfuggente malinconico amorevole
il +1
Chitarrista e produttore che ci porta nel suo iperspazio per farci sentire quanto è spigoloso e frenetico nonostante tutto il disco graviti su una melodia lontana che non sparisce mai in mezzo a bisturi molto ben definiti in un bel viaggio tortuoso ma pieno di luce.
UMIDO - Survivalismo futuribile
di Pietro Michi
La sopravvivenza è un elemento fondamentale della nostra vita, se non in quanto specie per lo meno come individui, e lo stesso si può dire per tantissime creature non umane.
Ma questa nostra esistenza è sempre più incerta, messa in discussione sì dagli allarmisti ma anche da ricercatori e intellettuali.
La fine sembra sempre dietro l’angolo: negli ultimi anni siamo sopravvissuti alla minaccia nucleare, al millennium bug, al calendario maya e al covid, e nel frattempo la lancetta del cambiamento climatico continua a ticchettare insieme ai vari disastri ambientali e alle tensioni geopolitiche.
A questo punto qual è quindi un futuro futuribile? Scompariremo tutti insieme o un po’ alla volta?
Il futuro più prossimo viene ipotizzato grazie a vari modelli previsionali più o meno affidabili, ma è anche stato provato a descrivere decenni fa da opere di fantasia scientifica aka sci-fi. Nella vasta gamma di testi e video fantascientifici potremmo trovare un 2024 raccontato come un futuro ai tempi plausibile, e potremmo fantasticare che in poche settimane potremmo davvero avere tutte quelle bellissime colonie su Marte. Oppure no…
In seguito agli ultimi decenni del ‘900 il futuro non è più tanto roseo neanche nella fantascienza: l’arrivo del cyberpunk, del post apocalisse e opere che ammoniscono l’umanità di grandi disgrazie quali i cambiamenti climatici e il sovrappopolamento come “Soylent green” (1977) o “The day after tomorrow” (2004). Fino ad allora la fantascienza più pop non era stata così inclemente con il futuro, e a parte qualche eccezione come “1984”, ancora dilagava il sogno della conquista dello spazio e del fenomenale ingegno umano.
Ai giorni nostri siamo distanti dalla natura impervia, anche se questa si sta avvicinando sempre di più a noi. Il nostro concetto di DIY si limita a realizzare costruzioni di carta e colla vinilica o a montare i mobili Ikea, e le abilità di caccia e raccolta sono anch’esse scarse.
Il nostro campo di addestramento sono i videogiochi survival, che ci insegnano come tener testa a un inizio di battaglia intra e inter specie. Riflessioni tristi, riflesso di un periodo triste in cui i genocidi sono appoggiati e finanziati dalle stesse potenze che da anni ci promettevano un futuro migliore.