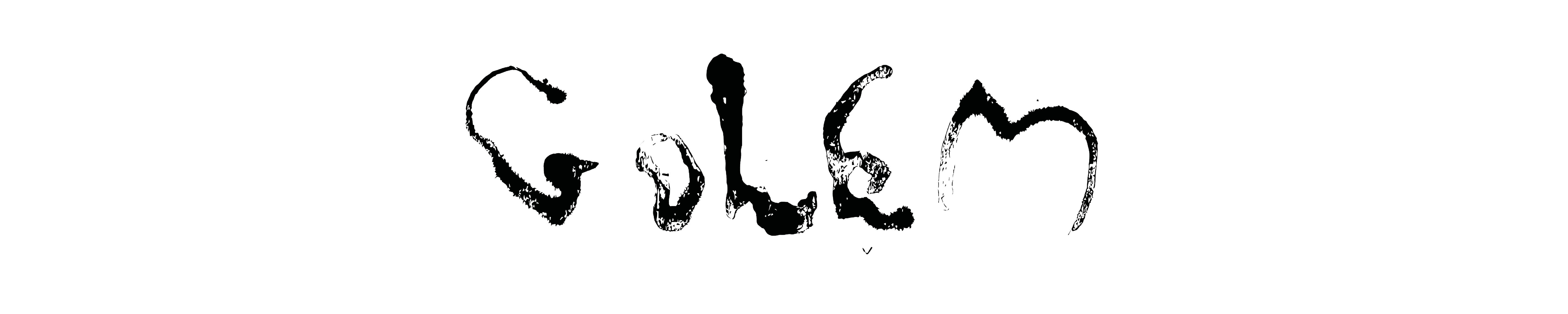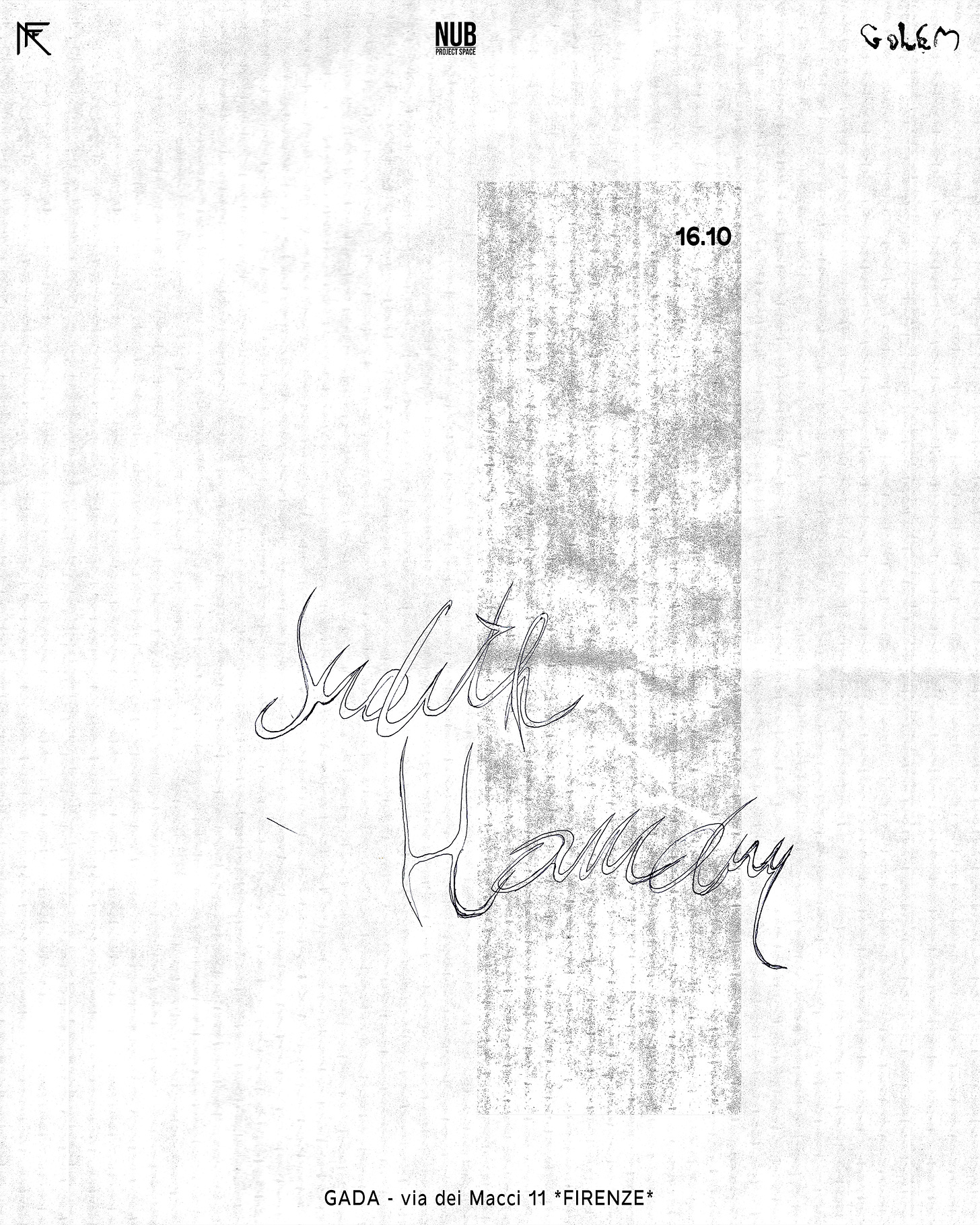Newsletter #025
Luglio Agosto Settembre Nero. Il fare musica per immaginare un futuro diverso
di Matteo Mannocci
La fine dell’estate 2025 ha lasciato nell’aria un odore di bruciato. Non solo metaforico. Una sollevazione popolare, improvvisa e inedita, ha attraversato le strade italiane. Dallo sciopero generale del 22 settembre si è aperta una mobilitazione permanente che ha toccato più di cento città. Per giorni, settimane, la geografia del paese è stata riscritta: porti bloccati, snodi logistici interrotti, autostrade e stazioni occupate, scuole e università trasformate in spazi di discussione.
In queste settimane milioni di persone di tutte le categorie e generazioni sono scese in strada, non solo per protestare ma anche per ricordarsi - o imparare - come si fa a essere molti, insieme, a chiedere le medesime cose e inventarsi un linguaggio comune. Durante le varie manifestazioni c’è stata una costanza che non si vedeva da vari anni: non una fiammata episodica, ma una combustione lenta e ostinata, capace di alimentarsi da sé.
Dopo che questo incendio si è consumato la prima domanda che tutti i movimenti si sono posti è stata: come si tiene viva una fiamma quando il vento smette di soffiare?
Se la risposta politica spetta ad altri spazi, forse qui su GOLEM possiamo tentare un’altra angolazione. Possiamo chiederci cosa resta, e cosa può nascere, nei luoghi in cui la politica incontra l’immaginazione. Come può l’arte — e più precisamente il fare musica — accompagnare una protesta, ispirarla o farsi laboratorio per nuovi linguaggi?
Dopo anni in cui la musica è stata inghiottita dall’estetica — e l’estetica dall’algoritmo — forse è tornato il momento di fermarsi un attimo. Di chiedersi non tanto come appariamo, ma come e perché si produce musica. Abbiamo passato troppo tempo a misurare la rilevanza di un progetto dal numero di collaborazioni con Balenciaga, dal feed cool e pulito o dalle apparizioni in eventi sponsorizzati da brand discutibili. E in questo panorama, forse, dovremo anche mettere da parte chi attraverso pose e produzioni patinate cerca di posizionarsi come artista radicale.
Per chi vuole stare dalla parte degli incendiari — non come posa, ma come scelta di campo — le strade sono molteplici, anche se ogni gesto ha un prezzo e una conseguenza. Nessuno può fingere che sia semplice, oggi, restare fuori dai circuiti che garantiscono visibilità, cachet decenti o un minimo di stabilità economica. Eppure, la questione morale non si risolve nel moralismo. È una questione concreta.
Cosa significa per un artista, in un’epoca di precarietà strutturale, dire no a un festival o a un’istituzione dal dubbio spessore morale? È una domanda che attraversa tutte le professionalità coinvolte: dai musicisti indipendenti ai tecnici del suono, dai curatori ai grafici, dai collettivi che organizzano eventi autogestiti ai singoli che campano di cachet intermittenti. E, allo stesso tempo, di un pubblico che può decidere di premiare quelle realtà più genuine e militanti, al posto di situazioni che spesso assomigliano più a showcase di agenzie pubblicitarie e di booking che altro.
Ogni volta che si accetta un ingaggio, si mette in gioco una parte di sé e una parte della propria idea di mondo.
E ogni volta che si rifiuta, si paga un prezzo in visibilità, sostentamento e possibilità future.
Il punto qui non è decidere tra noi un codice che possa concedere patenti di purezza, quanto il saper riconoscere le tensioni in corso e saper tenere una linea che riesca a unire coerenza e sostenibilità.
E questo implica domande scomode: quanti compromessi possiamo accettare senza trasformarci in ciò che volevamo combattere? Ma soprattutto, cosa succede se cominciamo a costruire — davvero — circuiti alternativi di sostegno, distribuzione e mutualità, che permettano di rifiutare senza scomparire?
Forse, proprio come le reti militanti riescono a coordinarsi intrecciando corpi, idee e logistiche fino a trasformare la frammentazione in forza collettiva, anche il mondo della musica -sperimentale, militante- dovrebbe cominciare a riconoscersi come rete.
Una rete non di marketing ma di mutuo appoggio, capace di collegare spazi, artisti, tecnici, ascoltatori; capace di costruire infrastrutture autonome che non dipendano da bandi istituzionali o da sponsor dalle mani sporche.
Una rete che possa ospitare e curare esperienze, residenze, festival diffusi, momenti di formazione condivisa. Luoghi dove il suono non è prodotto ma processo, esplorazione degli spazi e della propria percezione, per imparare ad ascoltare ancora prima che esibirsi.
Una rete che non abbia paura di dichiararsi partigiana, e che sappia ispirare chi ascolta a interrogarsi su nuovi linguaggi, modalità di presenza e forme di solidarietà sonora. Ma perché tutto questo possa accadere, non basta un’etica, quanto una pratica. Pratiche che rendano la scena non solo più coesa, ma anche più giusta, e soprattutto più sostenibile, pensando all’economia del suono come a un’economia del tempo e del sostegno reciproco.
Questo significa condividere risorse, attrezzature, spazi, contatti; sottrarre energie alla competizione e restituirle alla cooperazione, rifiutare la logica dell’artista-azienda e riscoprire la forza dell’agire collettivo.
Questo perchè la rabbia di queste settimane non deve estinguersi quando i social media smetteranno di esibire foto di bambini menomati o con la notizia di una traballante pace coloniale, ma ci ispiri per portare avanti una serie di iniziative collettive e che ispirino gli altri nel portare avanti la lotta, ognuno secondo quello che riesce a fare meglio, e integrando chi fruisce delle arti sonore come parte di un percorso collettivo.
In questo ricordarsi di esperienze come quelle dei Crass può sembrare banale, ma anche come un riferimento come a chi indica una possibile via da battere. Il collettivo inglese aveva capito che fare musica poteva essere un atto politico totale: non solo nei testi o nelle sonorità, ma nel modo stesso di produrla, distribuirla, viverla. Autonomia, autogestione, orizzontalità, rifiuto dell’industria culturale, coerenza tra mezzi e fini: il suono come comunità, la band come comune. Oggi, in un contesto radicalmente diverso ma per certi versi più urgente, quell’intuizione torna a parlarci, non come nostalgia di un’epoca “pura”, ma come promemoria su cosa può accadere quando il gesto artistico smette di essere individuale e diventa collettivo. Quando una canzone non è più proprietà di chi la scrive, ma patrimonio di chi la vive.
L’obiettivo non è romanticizzare il passato o costruire un’ennesima scena autoreferenziale. È, piuttosto, aprire possibilità: spazi dove la musica possa sostenere i movimenti, e dove i movimenti possano a loro volta sostenere la musica.
Quello che serve adesso è costruire le condizioni per far sì che questa energia non resti episodica, ma si traduca in reti durature, in pratiche comuni, in una cultura del suono che sappia stare dalla parte di chi resiste.
Segui GOLEM su Instagram:
16.10, ore 21, GADA Playhouse via dei Macci 11, Firenze
AFF & GOLEM, in collaborazione con NUB Project Space, presentano:
JUDITH HAMANN - LIVE
Ascolta CHIACCHIERE, il podcast di GOLEM su Fango Radio
IL DISCO DEL MESE
Touch This Fragrant Surface Of Earth- Marja Ahti (Fonstret)
ISCRIVITI E CONSIGLIA GOLEM
UMIDO - La zona umida
di Pietro Michi
È importante conoscere la zona umida: ambiente di compresenza tra acqua e terreno.
Spazio che non si lascia definire, né del tutto acqua, né del tutto terra.
“Ai sensi della presente Convenzione si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.”
— Convenzione di Ramsar, 1971
È un habitat per specie migratrici, anfibi, macroinvertebrati, microalghe, batteri e tante altre forme di vita che partecipano a reti trofiche complesse. Una zona di passaggio per molti organismi e di profonda e lenta simbiosi per altri. Uno spazio verticale, che si estende dal benthos del suolo sommerso al suolo ossigenato di superficie, fino allo strato epigeo dove vivono insetti, uccelli, vento.
La zona umida è bagnata. Ricoperta da quel fluido che è uno degli elementi fondamentali della vita: l’acqua, che rende tutto mobile e tutto aderente. Un tuffo nella palude ti avvolge di melma; un contatto ambiguo, di disagio o appagamento, secondo la propria disposizione, ti ricopre di piccole vite proliferanti. Ti invita in una zona di confine dove l’identità si diluisce e l’esperienza è condivisa. È una zona che può essere attraversata e vissuta non solo tramite il corpo.
La stabilità di una zona umida è delicata, richiede tempo, ma allo allo stesso tempo, è un sistema dinamico: il regime idrologico, la salinità, il pH, la torbidità cambiano con le stagioni, con le maree, con le precipitazioni. Processi come la successione ecologica modellano la comunità vegetale e animale. È una zona ricca di biodiversità e bellezze, considerata una fonte di conoscenza e un luogo di accumulo e dispersione. Un’installazione site-specific, uno spazio dove la vita non si esibisce, ma si manifesta.
Si deve infilare tutta la testa all’interno della zona umida, lasciare che tutte le molecole, liquide e solide, aderiscano alla faccia, penetrino nelle fessure. Dopodiché rimanere in ascolto. È importante entrare e rimanere nella zona umida per il tempo necessario, facendo sì che il flusso liquido diventi estensione della mente.